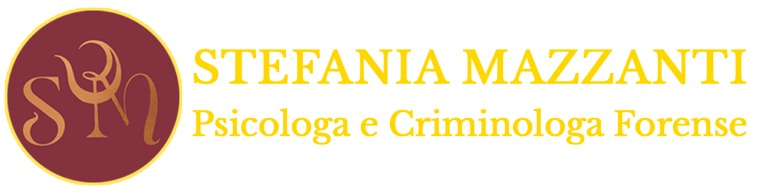Amore criminale, un ossimoro che affascina ancora oggi
Rivista Criminologia Italia - Diritto Più Edizioni
Anno 1 Numero 1 - Dicembre 2024.
Abstract
Amore criminale è una definizione acquisita dalla narrazione televisiva ed entrata nel linguaggio comune (1). Da questo accostamento si evince che possano coesistere amore e crimine, cioè un legame teso al raggiungimento della felicità dei partner, e un grave reato che può portare alla morte dell’altro. Tale abbinamento, ad una più approfondita analisi, risulta essere un ossimoro, figura retorica utilizzata in letteratura e poesia, che si basa sull’accostamento di due termini antitetici e inconciliabili, al fine di attirare l’attenzione del lettore e suscitare in lui sensazioni nuove e, magari, colmare vuoti semantici. Tuttavia l’uso che si fa del termine “amore criminale” sembra essere poco consapevole di tutto ciò, finendo per definire ogni amore che termina con un omicidio, solitamente della componente femminile della coppia. Questo fenomeno sta inculcando nella mente collettiva che possa esistere un rapporto d’amore caratterizzato da un progetto di vita insieme, che porti alla violenta soppressione di una delle componenti.
La realtà dei fatti ci mostra un paesaggio diverso, dove potrebbero esserci elementi psicopatologici, come la dipendenza affettiva, che andremo ad approfondire nella prima parte del lavoro, in cui risaliremo anche alle sue radici nell’ambito del rapporto con i genitori durante l’infanzia. Rapporto che, come vedremo, influenza l’idea che l’individuo sviluppa di sè e del mondo e, dunque, i suoi futuri rapporti interpersonali, soprattutto in coppia. Lì dove l’incontro tra partner che portano con sé particolari esperienze vissute da bambini può dar vita a relazioni patologiche, a collusioni che rendono spesso la convivenza infelice, turbolenta e che possono sfociare nella violenza di genere e nel femminicidio, l’omicidio della donna in quanto donna perpetrato nella maggioranza dei casi dal marito, dal compagno o dall’ex. Stiamo parlando di un fenomeno, quello della violenza domestica, che rappresenta la prima causa di morte o di invalidità permanente delle donne tra i 16 e i 50 anni! (2)
Dunque un fenomeno diffuso, che solo recentemente in Italia è venuto alla luce, mostrando anche il suo volto più legato agli stereotipi culturali di genere, come hanno messo in evidenza negli anni i movimenti femministi, che hanno portato ad una tardiva legislazione contro la violenza domestica e che continuano a resistere tutt’oggi anche nella narrazione mediale. Ne risulterà un quadro in cui, accanto alla malattia del singolo o della coppia, emerge una profonda malattia sociale, da poco presa in esame per essere affrontata grazie a leggi puntuali, caduta degli stereotipi, interventi di prevenzione e cura per vittime e carnefici.
Un quadro che mostra una rivoluzione ai suoi primi passi e fa ben sperare in un futuro prossimo in cui l’ossimoro “amore criminale” sarà visto come tale, in una società, appunto, che ben comprende la differenza tra finzione e realtà, così come la differenza tra amore e patologia.
1. Patologie all'interno del rapporto di coppia: le collusioni
La coppia si struttura nel tempo attraversando diverse fasi, a partire dall’innamoramento, quando l’individuo va incontro a un fenomeno di scissione dell’Io, in cui l’innamorato proietta sull’altro aspetti di sé idealizzati, riferiti in particolare all’ideale dell’Io, conducendolo ad una temporanea sospensione dello spirito critico. Questo meccanismo porta a vedere l’altro diverso da com’è realmente, in quanto filtrato dai propri desideri oppure, in altre situazioni, condizionato dalle paure personali. In questa fase di transizione si incontrano anche le rappresentazioni interne delle relazioni, che, come abbiamo visto, si strutturano attraverso i primi rapporti significativi, le precedenti esperienze sentimentali, le paure personali.
Mentre, però, in una relazione sana, a questa fase seguono degli aggiustamenti successivi in cui gli individui arrivano ad un nuovo equilibrio tra i bisogni di appartenenza e protezione e quelli di autonomia ed esplorazione, le relazioni patologiche rimangono cristallizzate in una situazione che amplifica le loro disfunzioni, spesso riproponendo dei copioni di modelli appresi nell’infanzia nel tentativo di risolvere una ferita emotiva subita.(3)
Secondo un punto di vista psicodinamico la coppia può fondarsi su un’intesa inconscia, un vincolo di collusione, attraverso il quale l’individuo proietta sull’altro parti di sé represse, manifestando nella relazione rapporti irrisolti del passato. Tale vincolo dipende dalle fasi di sviluppo della prima infanzia, nei quali, se il bambino non ha elaborato i conflitti relazionali con i genitori, da adulto tenderà a portare nella coppia la parte non risolta per poterla superare, ma in realtà non fa che riproporre le stesse modalità disfunzionali della prima infanzia. Così, nel gioco della proiezione di parti di sé indesiderate, il partner può diventare l’oggetto disprezzato da dominare, l’oggetto danneggiato che si vuole a tutti i costi riparare o il mezzo per confermare la propria onnipotenza.(4)
La collusione è sempre un processo relazionale, in cui, riferendoci alla teoria dei Modelli Operativi Interni (MOI), di cui abbiamo parlato nel precedente capitolo, l’attivazione di un particolare MOI da parte di un partner favorisce nell’altro l’attivazione di un MOI corrispondente, o complementare o simmetrico, e viceversa. Il problema è che nessuno delle due parti si accorge di essere attivo nella dinamica relazionale, vedendo esclusivamente la parte attiva dell’altro e considerandosi sempre e solo la vittima dell’attivazione dell’altro. Si crea, così, una situazione di tensione e stallo che si ripete nel tempo, producendo sofferenza, esasperazione, fino ad arrivare alla disperazione.(5)
Si parla, in particolare, di quattro tipologie di collusioni di coppia:(6)
la collusione narcisistica, che corrisponde ai primi mesi di vita del bambino, in cui egli vive in simbiosi con la madre. Si tratta dell’amore come fusione per il riconoscimento di sé, dove l’altro serve a confermare il proprio valore, altrimenti non sentito. Sono di solito due estremi che si uniscono, con una personalità narcisistica nell’uno, che vede il partner come prolungamento di sé, senza valore proprio, e una personalità senza o con scarsa autostima nell’altro, che vede solo nel rapporto il modo di brillare, però di luce riflessa.(7) Questa, come le altre tipologie di relazioni che qui vedremo, impedisce ai due di progredire e uscire dal dolore che entrambi vivono: il narcisista evita di affrontare il continuo bisogno di conferme e ammirazione, l’altro si impedisce di sviluppare una sana autostima grazie a una crescita personale e il riconoscimento del proprio valore.
La collusione orale, che deriva dalla relazione primaria tra madre-bambino nel primo anno di vita. Questo tipo di coppia è quello basato sulla dedizione totale di uno all’altro, con cure che ricordano quelle materne verso il bambino.(8) L’abbiamo già visto nella definizione di dipendenza affettiva e coinvolge una persona estremamente bisognosa o sfuggente e un “salvatore”, che si prodiga totalmente per il partner.
Fuori da questo tipo di relazione, l’uno potrebbe permettersi di diventare adulto e autonomo, l’altro potrebbe esprimere finalmente le proprie fragilità e bisogni, senza più doverli accantonare per dedicarsi al partner.
La collusione sadico-anale, che corrisponde alla fase dello sviluppo del bambino tra il primo e il terzo anno, in cui sperimenta le funzioni autonome dell’Io. Si tratta di un rapporto basato sul dominio che può manifestarsi secondo diverse collusioni. Ci può essere una collusione dominante-dominato, in cui il dominante, per la propria inconscia paura di essere sottomesso e dipendente, cercherà in tutti i modi di sottomettere l’altro, che si troverà a delegare ad esso la propria autonomia per non mettere a rischio il rapporto ed evitare il temuto abbandono. Una forma esasperata di questa situazione è la collusione sadomasochistica, in cui ci sono ruoli rigidi di persecutore-vittima ed entrambi le parti vivono una fusione che porta alla negazione di ogni forma di separazione, in quanto l’altro è ciò che colma il vuoto depressivo primario e tutela l’io dalla percezione di non esistere. È l’aggressività che in questa dinamica permette di mantenere il legame di dipendenza e che permette anche il soddisfacimento reciproco dei bisogni sessuali.
Un’altra collusione sadico-anale è quella basata sulla coppia antitetica e complementare infedele-geloso: l’infedele, attravero i tradimenti, nasconde il suo bisogno di autonomia e la paura di perdersi nell’amore fusionale, che proietta sul partner. D’altra parte il geloso esprime la sua angoscia di separazione e la sua paura dell’abbandono, trasferendo sull’altro le proprie fantasie di infedeltà e il desiderio di emanciparsi.
In questo ambito può esserci anche una collusione simmetrica in cui entrambi i soggetti sono dominanti e combattono per la supremazia all’interno della coppia, attuando continui scontri che sono il solo modo conosciuto per vivere la fusione e l’intimità con l’altro (spesso sono preludio all’incontro sessuale) e per sfogare il bisogno d’autonomia dai propri genitori, evidentemente ancora irrisolto.(9)
La collusione edipico-fallica, che deriva da un complesso di Edipo irrisolto, ossia da una relazione irrisolta con il genitore di sesso opposto. Questa è una coppia in cui è perenne la lotta per ricoprire il ruolo “maschile”. In una formazione eterosessuale ci saranno un uomo debole e una donna che sogna di ricoprirne il ruolo, emancipandosi attraverso l’assimilazione della figura maschile, considerata forse l’unica strada per esprimersi pienamente. La donna può scegliere un compagno che assomigli al genitore di sesso opposto (in questo caso potrà esserci una considerevole differenza d’età, proprio per riprodurre il rapporto con il genitore) oppure l’altro sarà l’antitesi del genitore in questione, che è stato magari un despota. Avendo con esso un rapporto ambivalente, la donna arriverà a non provare più interesse od odiare il compagno debole, cercando invece un partner forte come il genitore a cui è legata. Una variante di tale dinamica è quella degli amanti, in cui una persona sceglie di unirsi ad un’altra già impegnata, mostrando di covare, forse, il desiderio irrisolto di distruggere il rapporto tra i suoi genitori.(10)
La collusione è sempre un meccanismo protettivo, necessario ad entrambi le parti in gioco per rimuovere e proiettare l’uno sull’altro gli aspetti che non accettano in se stessi ed i conflitti irrisolti: questo legame disfunzionale non permette l’evoluzione dei partner e della coppia, provoca dolore e sofferenza e funziona fino a quando c’è un incastro nel soddisfacimento dei bisogni.
2.La violenza nella coppia
La situazione in cui entrambi i partner riescono a superare la collusione, trovando nuovi modi non collusivi di stare insieme o lasciandosi di comune accordo, è molto difficile. Spesso uno dei due partner riesce a cogliere la collusione e riesce a salvarsi venendo fuori dalla relazione, mentre l’altro non capirà e, dopo un periodo di lutto, tornerà a cercare un partner con cui ricreare la relazione disfunzionale.(11)
La collusione che continua a perpetrarsi, soprattutto nel caso di relazioni perverse a connotazione narcisistica o sadomasochistica, sfocia spesso in varie forme di violenza, come la violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica. La violenza psicologica può manifestarsi attraverso il controllo, l’isolamento, le umiliazioni, le minacce che provocano nell’altro insicurezza, paura e svalutazione di sé. In questo ambito rientra anche la violenza morale, intesa come atteggiamenti che vanno dalla derisione dell’altro, alla mortificazione, alla sopraffazione, fino ad arrivare ad un vero e proprio terrorismo psicologico, annientamento che vuole privare l’altro della sua individualità. Questa forma di violenza si sviluppa nel caso di un rapporto perverso di coppia in cui c’è sempre un’eccessiva responsabilizzazione di uno dei partner, che fa di tutto per soddisfare le richieste dell’altro nel tentativo di non scatenare la sua rabbia o di dimostrarsi all’altezza. In questi casi il violento può portare la vittima a sviluppare vere e proprie malattie mentali o al suicidio.(12)
La violenza fisica comprende diversi comportamenti che hanno lo scopo di far male o spaventare: dallo spingere, allo strattonare, al dare calci e pugni, al minacciare l’altro con un’arma. Spesso si tratta di aggressioni imprevedibili, che portano la vittima ad evitare qualsiasi comportamento che possano provocare la reazione del partner.
La violenza sessuale consiste nell’imposizione di rapporti sessuali indesiderati attraverso la forza o ricatti psicologici, così come l’imposizione di pratiche indesiderate o di rapporti che implicano la violenza fisica e/o psicologica. Questo tipo di violenza è quella che più difficilmente si riconosce all’interno della coppia a causa di resistenze socio-culturali che tendono a minimizzarla ed a ricondurla nell’ambito dei doveri coniugali.(13)
Nell’ambito della violenza economica, infine, rientrano quegli atteggiamenti che hanno lo scopo di impedire che il partner diventi economicamente indipendente, in modo da poter esercitare su di esso il controllo e spesso per non permettere all’altro di lasciare la relazione. Questo tipo di violenza è un aspetto di un contesto di violenza più complesso.(14)
Le conseguenze sulla vittima delle varie forme di violenza sono varie: lo sviluppo di sintomi psicopatologici legati a disregolazione affettiva, disturbo post traumatico da stress, disturbo depressivo maggiore, nonché aumento del consumo di alcolici e droghe.(15)
In rari casi l’esasperazione all’interno della coppia disfunzionale può arrivare all’omicidio, al suicidio o all’omicidio-suicidio. In particolare l’omicidio può verificarsi per due motivi opposti: impedire che il partner si differenzi, si imponga come soggetto rompendo il patto collusivo o eliminare la fonte di quel legame disfunzionale che non permette la realizzazione di sé. Nel caso dell’omicidio-suicidio sono presenti illusoriamente entrambi le motivazioni: uscire da una situazione senza via d’uscita e rendere eterna la relazione a cui non si può rinunciare, impedendo ad entrambi il tradimento del patto collusivo.(16)
Si tratta prevalentemente di coppie che hanno attuato il rapporto di dominante-dominato e per cui la fusione tra i due partner risulta ormai totale, tanto che la vita, senza la relazione con l’altro, sembra impossibile. Come per alcuni rapporti di dipendenza affettiva, prima del tragico esito si può sviluppare un andamento ambivalente, di odio e amore, di desiderio di fusione e ostilità. Il soggetto smette di riconoscere l’individualità dell’altro e crede di poterlo possedere totalmente, per questo rifiuta ogni possibilità che l’altro viva una vita autonoma.
3.Rapporti di potere: tra amore e dominio
La coppia può sviluppare un rapporto dove dominare ed essere dominati, prendere e accogliere si alternano in modo sano grazie a un gioco che rimane in equilibrio, oppure, come abbiamo visto, può dare vita ad una relazione in cui i partner rimangono imprigionati all’interno di ruoli rigidi che generano grande sofferenza e sfociano spesso nella violenza. Sino ad ora si è parlato in modo neutro, ma i dati statistici (17) mostrano chiaramente come più spesso l’uomo sia portato a valicare quell’equilibrio, trasformando ciò che dovrebbe essere amore in un rapporto di dominio.
Proprio su questo rapporto tra amore e dominio si è concentrata la psicoanalisi degli anni ‘70, nell’ambito del movimento femminista, rifacendosi a studi precedenti e superandoli per aiutare la donna ad uscire dal ruolo, non solo di dominata, ma di eterna madre, che produce una lotta, come poi vedremo, in alcuni casi fatale.
In particolare Benjamin (1988) sottolinea come alla base del dominio e della pratica di sottomissione ci sia la polarizzazione di genere, originata dalla concettualizzazione psicoanalitica freudiana della differenziazione sessuale del bambino e della bambina, che hanno in comune la mancanza di riconoscimento della soggettività materna.(18) Nella fase pre-edipica, il bambino risolve il paradosso di essere riconosciuto indipendentemente dalla persona da cui risulta dipendente, la madre, identificandosi con il padre in quello che viene chiamato “amore identificatorio”, cioè l’amore in cui la persona cerca nell’altro un’immagine ideale di sé, la somiglianza. D’altra parte, anche la bambina, nella lotta per l’individuazione, cerca un oggetto in cui riconoscere la propria indipendenza, ma quando il padre non si mostra disponibile si genera un’identificazione frustrata che la condanna ad un destino di passività (la cosiddetta “posizione della figlia”). Proprio la scissione tra un padre simbolo di liberazione, progressivo, e una madre simbolo di dipendenza, regressiva, struttura la polarizzazione di genere, in cui il maschile viene idealizzato e il femminile svalutato, in quanto contenitore passivo dell’attività maschile organizzata difensivamente. Questa scissione riguarda i bambini di entrambi i sessi, che sono nella condizione di dover barattare l’identificazione e l’identità con la madre con l’indipendenza, in altre parole nel rifiutare il ruolo materno, se non la stessa identità femminile.
La “posizione della figlia” pone la donna nella situazione di diventare oggetto del desiderio, in quell’oggettualizzazione che è alla base dei rapporti di dominio. La questione, però, non può essere vista unicamente come vulnerabilità della donna che diventa vittima dell’aggressione maschile, in quanto deve essere riconosciuta la complicità femminile nella relazione di dominio. La donna sogna di dominare mentre si sottomette e, in tali rapporti, arriva a idealizzare l’uomo, che sembra l’unico a poter vivere e avere quello che a lei manca: la piena realizzazione e l’autonomia. In questo modo finisce per negare la propria componente femminile nel momento in cui si dedica alla propria realizzazione, pensando che l’uomo che domina sia l’unico che possa compiere tale passo e che attraverso il dominio subìto la donna raggiunga, in qualche modo, anche la sua liberazione.
Queste riflessioni spingono verso il superamento della tradizionale concettualizzazione psicoanalitica, in cui la donna era vista unicamente come oggetto delle richieste del bambino, attraverso l’affermazione di una soggettività che è necessaria per fornire al figlio/a il giusto riconoscimento. Per uscire dalla complementarietà duale di soggetto-oggetto i soggetti devono prendere il posto degli oggetti, riconoscendosi reciprocamente, in modo che l’identità e la differenza esistano simultaneamente in una intersoggettività finalmente slegata dalle logiche del dominio.
P. Serra, Amore Criminale - RAI 3 - Quali effetti sul pubblico? Lettera aperta al Presidente della RAI, in https://rolandociofi.blogspot.com (consultazione del 5 maggio 2021).
PoliS-Lombardia, Le invisibili:la violenza di genere in tempi di lockdown, novembre 2020, p. 6.
A. Rossi, Delitti d’amore, quando la passione si trasforma in crimine, AIPG, Associazione Italiana di Psicologia Giuridica, Roma, 2008, p.6.
Giusti, E., & Mazzei, M. (2020), Consulenza di coppia. Superare le crisi transitorie verso il rinnovamento con metodologie sistemiche e tecniche strategiche. Roma: Armando Editore, p.42.
Roccato, P.(2017). La collusione "verso un unico soggetto". In C. Arnetoli, R. Di Frenna (Ed.), Percorsi di psicoanalisi contemporanea: radici e prospettive (p.120). Torino: Rosenberg & Sellier.
Cfr. Willi, J. (2001). La collusione di coppia. Milano: Franco Angeli.
Perrone, V. (2014). Psicopatologia delle relazioni di coppia: gli “incastri perfetti”. Mente e cura, 1-2, 170.
Ivi, p. 176.
Ivi, pp. 173-177.
Ivi, p. 178.
Roccato, P. (2017). La collusione, cit., pp.135-136.
V. Perrone, Violenza Intrafamiliare e prospettive di intervento: paradigma psicologico, in www.aipgitalia.org (consultazione del 10 marzo 2021), pp. 32-33.
Ivi, p.34.
Ivi, p.35.
Miano, P, & Damiano, R. (2018). La sicurezza dell’attaccamento in madri e figli esposti a violenza domestica. In A. Merenda, P. Miano (Ed.), Caregiving e attaccamento. Una lettura dinamica dei contesti di accudimento (p. 44). Palermo: Palermo University Press.
Roccato, P. (2017). La collusione, cit., p.135.
EU.R.E.S., Sintesi del VII rapporto sul femminicidio in Italia, in www.eures.it (consultazione del 25 novembre 2021).
Cfr. Benjamin, J. (2015). Legami d’amore: i rapporti di potere nelle relazioni amorose. Milano: Raffaello Cortina Editore.